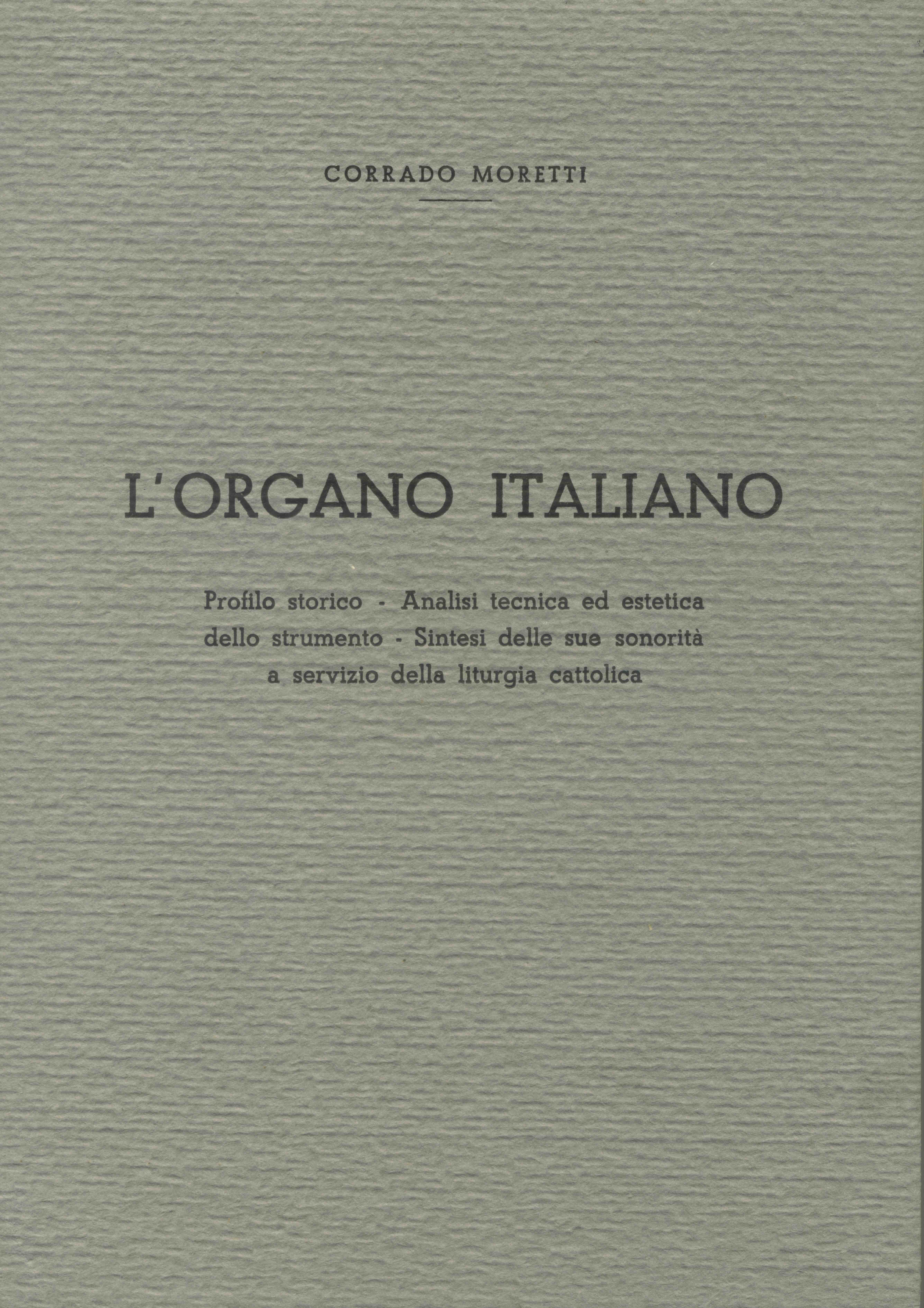
Corrado Moretti [*]
L'ORGANO ITALIANO
Profilo storico – Analisi tecnica ed estetica dello strumento – Sintesi delle sue sonorità a servizio della liturgica cattolica
Prefazione di Renato Lunelli
Tavole illustrative di Carlo Vegezzi-Bossi
26 fotografie fuori testo
Edizioni S.A.S.T.E. – Cuneo (1955)
Proprietà letteraria ed artistica riservata a termini di legge.
Edizione tutelata dall Commissione Organaria Subalpina presso la Soprintendenza alle Gallerie del Piemonte (Palazzo Carignano in Torino)
Fotografie eseguite da: Alinari (Firenze), Bonansca (Mondovì), Cianciafara (Messina), Masiconi (Cuvio), Neocolor (Milano), Publifoto (Torino), Rampazzi (Torino), Ricci (Crema), Ruffatti (Padova), Scoffone (Cuneo), Villani (Bologna), Zani (Milano).
Nulla osta:
Santuario Basilica di Vicoforte Mondovì, 1 agosto 1955, Can. M.° Andrea Airaldi Rev. Eccl.
Imprimatur:
Mondovì, 7 agosto 1955
✝︎ Sebastiano Briacca, vescovo
*
AI SOMMI PONTEFICI
Padri dell'Era Liturgica della Chiesa Cattolica
enunciatore dei principi di estetica sacra
nel quadro della restaurazione universale in Cristo
che all'organo confermò i titoli della sua millenaria nobiltà
perché sposo ai riti santi del tempio
felicemente regnante
che col magistero, la carità e le generose riforme
emula la gloria di s. Gregorio Magno
quest'opera
ispirata alle supreme direttive di documenti
che da Loro prendono nome ed autorità
l'autore filialmente dedica
auspicando che l'organo
pontefice degli strumenti musicali
canti perenne lode a Dio
e devota riconoscenza al Pontificato Romano.
*
PREFAZIONE
L'organo comincia finalmente a destare l'interesse degli studiosi italiani.
È la terza volta che in breve giro di tempo devo fare da padrino a pubblicazioni italiane, dedicate all'organo ed ai suoi problemi specifici. Altri lavori del genere sono in preparazione avanzata, sempre dovuti ad appassionati studiosi italiani. La strada a queste opere impegnative e di una certa mole – che in ogni caso va oltre i limiti di singole monografie su particolari argomenti organari – venne aperta in questo dopo guerra da Fernando Germani, col volume edito nel 1952 e dedicato all'arte della registrazione, nel quale è in primo piano l'organo delle varie nazioni, nelle più svariate forme antiche e moderne.
In Italia non si ebbe mai una simile fioritura di scritti attorno all'organo. Ma il lavoro che presenta Corrado Moretti è il più italiano di tutti; è permeato di una italianità schietta e sicura di sé, che non sta solo nel titolo.
Il mantener salde le proprie posizioni genera fiducia anche in chi dalla sorte è condotto a calcare la stessa terra. Il lettore, che vorrà leggere l'agile trattazione del Moretti, potrà gustare, in una cornice di ottimismo sereno, un panorama nitido e suggestivo come quello che si ammira dal Belvedere di Mondovì, «tra 'l monte e il verdeggiar de' piani». E una lieve tinta di compiaciuta regionalità piemontese colorisce anche il libro del Moretti: ma a buon diritto. L'organo italiano della prima metà del novecento, sul quale soprattutto l'autore vuole richiamare l'attenzione, ebbe la sua definitiva impostazione nel Piemonte. Era perciò giusto che un piemontese competente in argomento si accingesse ad illustrare la situazione attuale, chiarendo le aspirazioni artistiche, verso le quali si protese l'organo italiano nella prima metà del nostro secolo.
La tecnica di per sé non può, da sola, dare un'impostazione artistica dello strumento: il problema estetico dell'organo è di altra natura. Alla soluzione del quale mirarono due illuminate figure piemontesi: Carlo Vegezzi-Bossi e Giacomo Sizia. Il primo, con raffinata sensibilità di intonatore, creò attorno ai suoi organi un'atmosfera sonora, frutto di geniale fusione della tradizione classica italiana, colle risorse timbriche dell'organo romantico estero; il secondo, sorretto da tenace passione di amatore, analizzò con acuta penetrazione le possibilità foniche dello strumento alla luce di una estetica, che se dal clima romantico prendeva le mosse, andava ben più oltre, fino all'esaltazione dei valori perenni delle sonorità organistiche.
La rinascita dell'organo italiano del primo novecento è tutta impostata – sia pure con inevitabili oscillazioni – sulle direttive estetiche propugnate e diffuse dalle forse piemontesi, che con tanto successo erano venute affermandosi.
Il lato debole fu di aver trascurato le sonorità dell'organo antico non italiano. Ma di ciò non si può far colpa al movimento stesso, perché questi timbri di gusto arcaico, anche all'estero, erano ormai considerati cosa superata. Fa invece onore ai riformatori italiani la tenacia nel conservare immacolato da deturpazioni il nostro classico Ripieno. È vero: pure il Sizia – spinto dalla corrente – scrisse che per l'organo da concerto «non ha importanza la bellezza del Ripieno, mai adoperato da solo». Anche in questo caso, però, la colpa è tutta della decadenza dell'arte organistica o almeno del predominio imposto dal gusto romantico. Oggi si giudica ben diversamento.
Col suo lavoro il Moretti fa il punto sulla presente situazione dell'organo italiano e ne esamina, con soddisfazione, i frutti portati da un movimento, che diede all'arte italiana una ricca fioritura di strumenti degni di alta considerazione, qualunque sia il giudizio estetico che se ne può trarre, a seconda della posizione dalla quale si prendono le mire.
Con queste analisi, che investono la storia dell'organo, la sua struttura tecnica, le sonorità che gli sono proprie, il Moretti non trascura di scendere al lato pratico sul miglior modo di valorizzare lo strumento e mira soprattutto a guidare «gli organisti alla conoscenza scientifica ed estetica degli innumerevoli organi che oggi possediamo, facendone rilevare pregi e lacune attraverso il miglior uso quotidiano, per prerararli a vagheggiare amorosamente l'organo di domani».
Ma, l'autore, nella sua sicurezza del presente, non vuole entrare in problemi futuri; osserva solo che «l'organo italiano non si è ancora fissato uno schema fonico definitivo». In perfetto stile! Una natura così propensa a presentare le cose nella loro oggettiva concretezza, non poteva pensare al futuro dell'organo se non in forma di una necessaria schematizzazione. Ma l'organo, appunto perché opera d'arte, non può essere legato a paradigmi: esso è in continua evoluzione; è una forza che percorre la propria orbita, senza mai fermarsi, assumendo sempre aspetti e forme nuove, secondo le necessità estetiche del momento.
È sperabile che a nessuno venga la malinconica idea di fissare lo schema dell'organo italiano futuro. Ci auguriamo invece che fra parecchi decenni il Moretti possa riprendere il suo odierno discorso e fare il punto sullo strumento che brillerà in futuro sul nostro orizzonte organario, come oggi, con grande profitto di tutti, egli seppe tratteggiare un bel panorama dell'organo italiano del tempo nostro, esposto con oggettiva concretezza.
Ma allora, purtroppo, io non potrò più avere il piacere di far da padrini al nuovo lavoro.
Trento, S. Lorenzo 1955
* * *
NOTA DELL'AUTORE
Nel dare alle stampe questo lavoro, desidero esprimere viva gratitudine a molte persone.
Ai miei maestri d'organologia già passati a miglior vita: Giacomo Sizia, Ulisse Matthey, Francesco Vegezzi-Bossi; e poi, tra quelli che sono in pieno fervore di opere, a Renato Lunelli, Carlo Vegezzi-Bossi junior, Ferruccio Vignanelli. Li ringrazio non solo per quanto ho da loro imparato, ma anche perché, tutti di me più anziani, mi hanno sempre aperto l'animo, sui problemi dell'organo, con una fraternità così generosa e senza riserve, che, nel mondo egoista d'oggi, è assai rara.
Ad altri più vicini alla mia vita quotidiana, superiori ecclesiastici e confratelli, devo riconoscenza per le insistenze con cui amabilmente hanno sollecitato il compimento dell'opera. Da qualche anno era pronta la materia ed aggiornato lo schedario, ma la stesura definitiva maturò a rilento: non per mancanza d'entusiasmo, ma perché il ministero in parrocchia, nei seminari diocesani, nel movimento promosso dal Centro di Azione Liturgica mi permettono poche digressioni nel solenne ideale mondo dell'organologia, in cui mi rifugio, con spirituale profitto, ogni volta che posso.
Grazie anche a quanti avranno la pazienza di leggere, la benevolenza di comprendermi e la sincerità d'inviare le loro osservazioni.
Ma sopra tutto ringrazio umilmente Iddio e s. Cecilia, se queste pagine riusciranno a fare un po' di bene.
Vicoforte - Mondovì, nella Festa dell'Assunzione di Maria Santissima, 1955
Sac. Corrado Moretti, parroco ai Ss. App. Pietro e Paolo
[*] Il sacerdote, liturgista, musicologo e organologo Corrado MORETTI (Trigolo, 19 marzo 1913 - Cima Marguareis, 11 luglio 1974) venne nominato Prelato d'Onore di Sua Santità dal papa Paolo VI nel 1971 per i meriti in campo sia liturgico che musicale. Ricoprì anche l'incarico di Ispettore Onorario del Ministero della Pubblica Istruzione per le Antichità e le Belle Arti. Nel 1974 a Loreto ricevette il premio "Una vita per la musica". Risalgono al 1941 i suoi Appunti di organologia.
