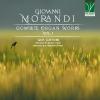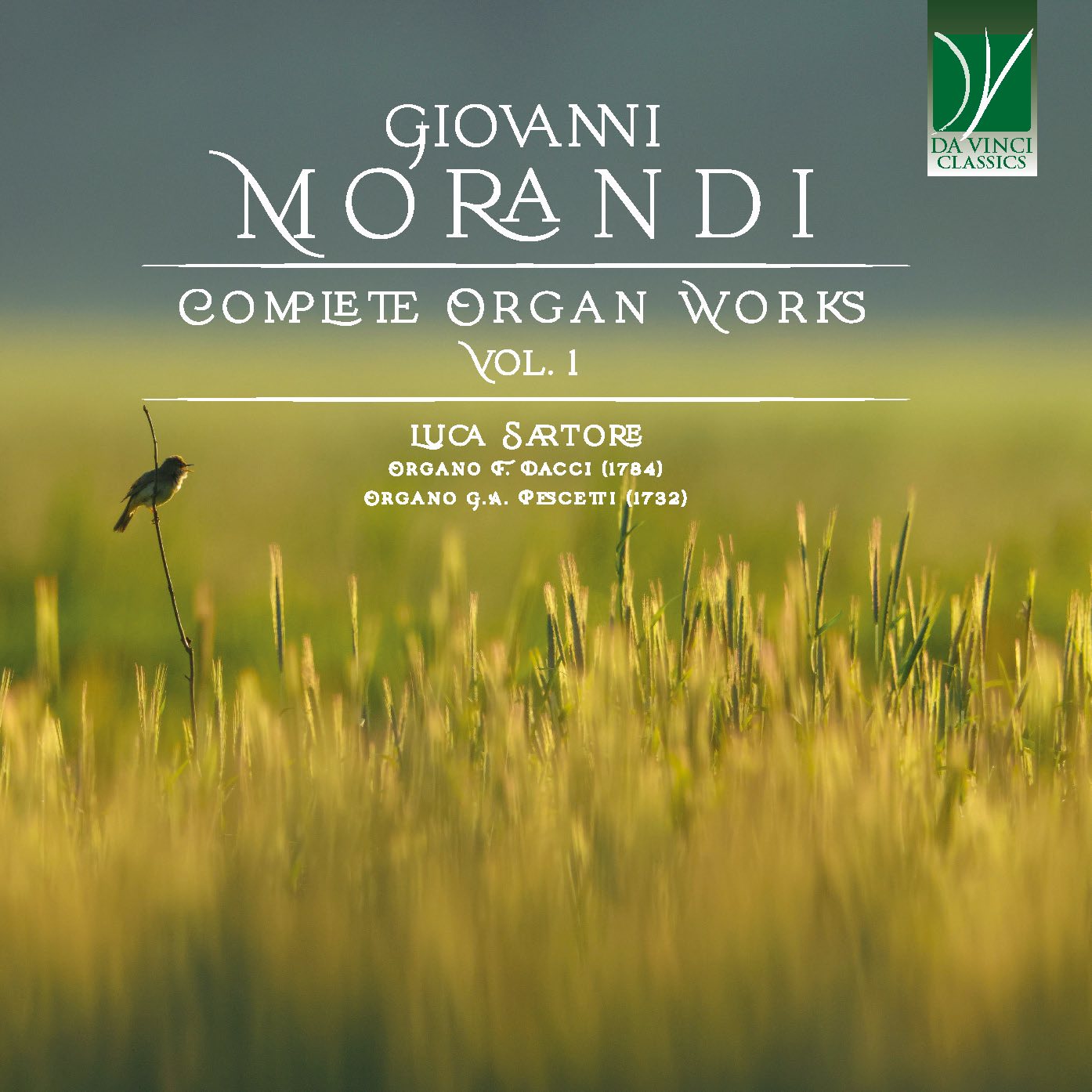
GIOVANNI MORANDI (1777-1856)
COMPLETE ORGAN WORKS Vol. 1
Da Vinci Classics C00715
Organo "E. Dacci" (1784), Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria, Santa Maria in Punta / Organo "G.A. Pescetti" (1732-33), Chiesa di S. Giacomo, Polcenigo
Splendido esordio per questa nuova integrale organistica dedicata a Giovanni Morandi dal bravissimo Luca Sartore
di Alberto Pedretti
Una gioia per tutti gli appassionati del repertorio definito incautamente decadente, questa nuova iniziativa discografica firmata Da Vinci Classics ed affidata al bravissimo Luca Sartore. Il valore artistico di Giovanni Morandi (Pergola, 1777 – Senigallia, 1856), infatti, è stato a lungo sottostimato, nelle trattazioni storiche come nella memoria collettiva locale.
È risaputo che la letteratura italiana per organo nell’Italia del primo Ottocento, continua tranquillamente sulla strada segnata da quella della fine del secolo precedente. I nostri organisti, continuarono infatti a scrivere ed eseguire sonate bipartite, sinfonie, versetti, elevazioni, pastorali, ecc... ispirandosi sempre più all’opera lirica, spesso riproducendola tale e quale in riduzioni per organo. In questo particolare periodo storico l’intenzione era quella di intrattenere i fedeli in un onestissimo e spensierato divertimento, con passaggi dal sentimentale al magniloquente, dal devoto al ballabile. Come si è sentito dire fino alla noia, l’organo fu a tal punto privato della connotazione religiosa, da farsi orchestra e banda per i poveri, ai quali era precluso il teatro lirico. Con questa accusa che personalmente ho sempre trorvato fuori luogo, una classe organistica “benpensante” ha cancellato con un abile colpo di spugna uno dei periodi più belli e coloristici della produzione organistica. D’altronde, questa affermazione trita e ritrita, l’abbiamo già sentita alla noia, riferita non solo all’Italia, ma anche alla Francia di Louis James Alfred Lefébure-Wély ed Eduard Batiste, salvo poi scoprire che il primo fu genio assoluto che traghettò la musica tardo barocca di Claude Balbastre, Louis-Nicolas Sejan e Jean-Jacques Beauvarlet-Charpentier al primo approccio sinfonico che sarebbe sfociato in César-Auguste Franck e Charles Marie Widor. Quanto agli strumenti, l’accusa cadde su due dei più nobili organari italiani, i Serassi ed i Lingiardi, che fecero di un sol boccone generazioni passate e future di costruttori con la loro sapienza nell’intonare ance e ripieni, così come nel creare registri di percussione straordinari (Campanelli, Timballi, Rollanti e Grancasse, Banda Turca), che mandarono finalmente in pensione i miseri Zimberstern barocchi.
Lasciando quindi da parte queste malelingue, l’Ottocento italiano fornì alle cronache veri e propri personaggi di primo piano quali Felice Moretti, noto come Padre Davide da Bergamo (Zanica 1791 – Piacenza 1863), Vincenzo Petrali (Crema,1832 – Bergamo, 1889) e proprio Giovanni Morandi (Pergola, 1777 – Senigallia, 1856), da molti considerato il principale compositore di musica per organo dell'Ottocento italiano.
Nato a Pergola, una piccola città dell’entroterra marchigiano, il 12 maggio 1777, Giovanni ricevette la prima istruzione musicale dal padre organista Pietro Morandi (1745-1815), Accademico Filarmonico, originario di Bologna ed ex allievo del celebre Padre Martini, nonché autore di XII Concerti per organo. Maestro di Cappella a Pergola (1764-1778), attivo come compositore di musica teatrale, sacra e per organo, eccellente maestro di canto, fra i suoi allievi possiamo annoverare Angelica Catalani, Girolamo Crescentini e Luigi Bassi. Nel 1778 Pietro Morandi fu nominato Maestro di Cappella presso la Cattedrale di Senigallia, incarico che ricoprì fino al 1811, e si trasferì con la famiglia nella nuova città, tutt’ora famosa per la fiera che vi si teneva in estate e che era la principale dello Stato Pontificio.
Dopo gli anni di apprendistato sotto la guida paterna, trascorsi nell’assisterlo durante le funzioni sacre e nella scuola di canto, Giovanni trovò impiego come maestro al cembalo nella stagione teatrale della fiera di Sinigallia nel 1803. L’anno successivo Giovanni sposò Rosa Morolli, sua allieva di canto, destinata ad una brillante carriera: dal 1804 al 1824, anno della morte, Rosa Morandi comparve sulle scene di Bergamo, Bologna, Brescia, Cesena, Crema, Cremona, Faenza, Ferrara, Firenze, Genova, Lucca, Lugo, Mantova, Parma, Pisa, Ravenna, Reggio Emilia, Roma Senigallia, Siena, Torino, Trieste, Venezia, Vicenza, Milano e persino Parigi (Théâtre des Italiens nel 1813-1815, e nel 1816-1817). Per la sua voce scrissero prime parti di opere Donizetti, Farinelli, Fioravanti, Mercadante e Rossini. Morandi seguì la moglie costantemente nei faticosi spostamenti e la sostenne come intermediario nelle trattative con gli impresari, mettendo a sua disposizione la sua esperienza d’insegnante di canto. I frequenti viaggi nelle diverse città d’Italia costituirono per il giovane musicista occasione di lavoro ed arricchimento intellettuale. I contatti con l’ambiente teatrale gli consentirono di far eseguire alcuni suoi lavori drammatici e rafforzarono la sua conoscenza degli stili e delle tecniche vocali. Tra il 1805 d il 1810, scrisse per i teatri di Mantova e Ferrara, La Pergola di Firenze ed il Valle di Roma; nel 1814 lo ritroviamo come maestro di cembalo al Théâtre des Italiens a Parigi. La frequentazione di ambienti musicali disseminati nella penisola italiana ed a Parigi gli permisero di approcciare i più diversi stili compositivi, soprattutto in ambito teatrale, dei quali potéfare tesoro come compositore di musica vocale e d’organo. Stando a quanto riferisce un suo allievo, Arcangelo Boccoli, al 1810 risale l’episodio più importante della sua vita. Morandi avrebbe infatti avuto un ruolo decisivo nell’avviamento alla carriera teatrale dell’allora diciottenne Gioacchino Rossini. I Morandi erano infatti in familiarità con i genitori del pesarese. Essendo venuto a mancare un compositore per la stagione d’autunno 1810 al Teatro San Moisè di Venezia, presso il quale era scritturata Rosa, Giovanni suggerì all’impresario di chiamare il giovane Rossini (che esordirà con La cambiale di Matrimonio con Rosa Morandi nella parte di Fanni) e, di fronte alle proteste dei cantanti che lamentavano una scrittura orchestrale invadente, suggerì al giovane quali cambiamenti apportare alla partitura. È proprio nei primi anni trascorsi al seguito della moglie Rosa, che Morandi entra in contatto con l’editore Giovanni Ricordi; questi, che aveva aperto a Milano nel 1908 una casa editrice, inserì tra le sue prime pubblicazioni opere per tastiera di Morandi, come la Prima Raccolta di Sonate per Organo ed i Sei Valzer e un Rondò per pianoforte 1.
La morte di Rosa, avvenuta inaspettatamente nel 1824, determina un cambiamento radicale nella vita del Morandi: tornato a Senigallia, tranne pochissimi spostamenti nei successivi 32 anni della sua vita, rimane nella città rinunciando a qualunque ingaggio che lo possa allontanare dalla famiglia. In questi anni mantiene comunque contatti con la vita musicale che si svolge al di là dell’ambito provinciale. Diviene corrispondente dell’editore Ricordi, al quale si deve la pubblicazione della maggior parte delle sue composizioni per organo, ed è pertanto aggiornato sull’evolversi della produzione musicale a livello nazionale. I contatti con gli editori (Andrè di Offenbah, Cipriani di Firenze, Giuseppe Magrini di Torino, Lucca e Ricordi di Milano) gli garantiscono la diffusione di quasi tutte le sue partiture. Dal 1824 al 1836 lo ritroviamo come Maestro di Cappella presso la Cattedrale, direttore musicale nelle stagioni di fiera 1830, 1832, 1833 in teatro e fondatore della Società dei filomusicori (allo scopo di favorire l’educazione musicale ed organizzare concerti),che poi trasformerà in scuola gratuita di canto, suono e composizione, una delle più importanti della regione. Ha inoltre contatti con diversi monasteri femminili, per i quali scrive una quantità di musiche per organo e composizioni sacre per voci e organo: S. Cristina di Senigallia, S. Carlo e S. Maddalena in Serra de’ Conti.
L’attività compositiva di Giovanni Morandi trova una certa corrispondenza nelle proprie vicende biografiche, nel senso che la morte di Rosa costituisce un punto di svolta nei generi praticati. I pochi lavori drammatici furono scritti nell’arco di tempo che va dal 1805 al 1813: ricordiamo le farse Pigmalione, Il facchino onorato, Il Brentatore geloso, rappresentate rispettivamente a Mantova (1806), Ferrara (1806) e Mantova (1807). Ben diversa la situazione posteriore al 1824: Morandi compose infatti quasi esclusivamente musica sacra ed organistica, pubblicata quest’ultima con fervore tra il 1817 ed il 1824 e, successivamente, dal 1827 al 1848.
Attivo fino agli ultimi mesi della sua vita, ha lasciato centinaia di composizioni: la sua produzione autografa, tuttora conservata presso il Monastero di S.Cristina a Senigallia, comprende 700 partiture. Tra queste oltre 260 composizioni per organo, circa 450 brani sacri per una o due voci e organo, genere che trovò diffusione capillare in area marchigiana, come dimostrano le musiche rimaste presso gli archivi ecclesiastici. A queste si aggiungono, fra le stampe, circa 150 pezzi per organo di stampo brillante, ed infine brani pianoforte e per voce.
Le composizioni per organo, comprendono: Sonate per gli organi moderni, in 12 raccolte; Raccolta di Sonate per gli organi moderni, in 8 fascicoli; Gran sinfonia con variazioni; Pastorale con l’imitazione del suono de ’zampognari (1822); Il santo Natale; 6 Sonate; Pastorale; Nuova pastorale; Sinfonia in pastorale per il SS. Natale; Raccolta di Suonate per gli organi moderni; Raccolta di Sinfonie; Suonate per l’accompagnamento di una Messa solenne; Marcia militare da eseguirsi nelle processioni ed il celeberrimo Rondò con imitazione de’ Campanelli in Fa, tanto eseguito. Alcune sue partiture (Ouverture in mi; Offertoire in fa) furono arrangiate per organo sinfonico inglese, mentre altre 18 figurano nella raccolta Organ Compositions edited ed arranged for English Organs by W.T.Best, il celeberrimo concertista della St.George’s Hall di Liverpool, a dimostrazione di quanto la musica del Morandi godette di considerazione e plauso anche in campo internazionale. In edizione moderna, ricordiamo infine due volumi di Musiche per gli organi moderni, nella raccolta “Biblioteca classica dell’organista”, dell’Editore Paideia, che racchiudono quasi cinquanta pezzi, nello stile di Padre Davide da Bergamo.
L’arco cronologico coperto dalle composizioni per organo ha per estremi gli anni 1826 e 1854, ma la maggior parte dei lavori si colloca nel periodo che va dal 1836 (quando cessò il suo incarico come maestro di cappella presso la Cattedrale di Senigallia) al 1852. Le musiche rimaste preso il Monastero furono invece composte per le monache di S. Cristina (Senigallia) ed in misura minore per S. Carlo (Serra de’ Conti, AN). Si tratta di Sonate, Marce militari, trascrizioni e Pastorali, concepite per il culto ma anche come materiale di svago per le organiste del Monastero.
Diversa la situazione per la musica destinata alle stampe, che aveva come riferimento un pubblico più vasto, ed è quindi più accurata e di maggiore impegno: vi troviamo Pastorali, Sinfonie per organo e Raccolte di Sonate.
Il CD di Luca Sartore si apre con la “Prima Raccolta di Sonate”, comprendente sette Sonate pressoché sconosciute,probabilmente le prime affidate alle stampe da Giovanni Morandi. La suggestiva stampa del manoscritto reca in copertina:
Sonate per organo / composte dal sig.r maestro / Giovanni Morandi / Raccolta / Proprietà dell’editore. Deposta alle Biblioteche Reali ed Imp.le / Milano / Presso Giovanni Ricordi, Incisore, e Nego.te di musica Cond.da S.a Margherita / Felice Festa Editore, ed Incisore di musica a Turino / Fratelli Reyceland Libraj a Turino.
Alla fine dell’ultima Sonata, è inoltre segnato: felix festa incisit. Esemplari a stampa della Prima Raccolta di Sonate, sono conservati presso la Biblioteca del Conservatorio "G. Verdi" di Milano, la Biblioteca Marciana di Venezia , la Biblioteca musicale “G. Greggiati” di Ostiglia e, in forma incompleta, presso il Monastero Benedettino di S .Pietro a Cres, in Croazia.
Pubblicate nel 1808 con numero di lastra 5 e dunque appartenenti al primissimo gruppo di stampe uscite dalla neonata Casa Ricordi, le Sonate figureranno poi nel primo Catalogo della Casa Editrice Ricordi (1814) con la denominazione “Varie sonate per organo” e, finalmente, in quello del 1828 con la denominazione “Sonate. I raccolta”.
Nello stile, nella mancanza di indicazioni sulla destinazione d’utilizzo e nel comparire quindi come brani isolati a sé stanti, queste prime Sonate del Morandi si differenziano nettamente dalla Seconda Raccolta, pubblicata nove anni dopo, nel 1817, e dalle successive, se si eccettua la Gran Raccolta di sonate edita da Cipriani nel 1823-24. Le Sonate 1-3 riportano come indicazione di tempo Largo Maestoso, Allegro con brio – Grave – Allegro con brio; le 4-6 riportano Allegro – Adagio – Allegretto; la settima, infine, è un Largo a sé stante, costituito da una struttura libera, che viene introdotta da una successione di accordi e sfocia poi su figurazioni libere sopra il pedale. Vera e propria perla della raccolta, la Settima Sonata, è costruita nella forma del Plein jeu alla francese, splendidamente arricchita ed abbellita da Luca Sartore nell’esecuzione qui registrata.
La scrittura che pervade questa raccolta, così ricca d'inventiva2 e orientata verso il secondo Settecento strumentale italiano, col classico schema architettonico della sonata bipartita che alterna episodi sul Tutti (riservato agli episodi di transizione, sviluppo e cadenze) ad altri affidati ai Soli (destinati ai temi principali) per variare il gioco di colori, ridimensiona l'immagine corrente di Morandi come un autore fortemente influenzato dall'opera; le sette Sonateconfermano piuttosto, nel confronto con la successiva produzione, il suo saldo possesso delle architetture formali, anche se non manca, qua e là, l’aspetto fracassone che tanto ha fatto scatenare l’ira dei puristi nei secoli successivi.
Con la Seconda Raccolta di Sonate, che consiste di sole tre composizioni, si cambia decisamente musica. La percezione è abbastanza evidente. La scrittura, che ricorre spesso al basso albertino diventa progressivamente più ricca e complessa. Se è vero che le sonate di Morandi restano fondamentalmente estranee allo spirito da ballo riscontrabile in molte musiche per organo del periodo, è comunque vero che un forte influsso è esercitato su di esse dalla musica d’opera: a questa si richiamano spesso la conformazione dei temi (quasi sempre di carattere cantabile), le formule di accompagnamento e soprattutto gli schemi formali. I brani si alternano nei tempi Allegro con spirito – Andante sostenuto – Maestoso, Andante brillante - tripartizione che Morandi riproporrà fino alla Quinta Raccolta di Sonate del 1825 - tempi destinati ad Offertorio, Elevazione e Postcommunio. In aggiunta possono essere presenti altri tempi quali Marcia militaree Benedizione del Venerabile.
L’Offertorio, in generale, corrisponde ad una “Sinfonia avanti l’opera” e ne segue lo schema formale diffuso agli inizi dell’Ottocento: introduzione lenta, nel caso di Morandi caratterizzata da instabilità armonica, seguita da sezione principale veloce. L’Elevazione, lenta e dal carattere cantabile è dominata dall’inizio alla fine dalla stessa sonorità, abitualmente la Voce Umana o Fiffaro 8’. Spiccatamente vivace il Postcommunio.
La Prima Sonata in Do Maggiore porta la dicitura “Sinfonia con l’imitazione di Grand’Orchestra”. La Seconda, in La minore “Adagio con l’imitazione di Voce Umana”. La Terza Sonata, in Fa Maggiore è la celeberrima “Introduzione, Tema con Variazioni e Finale con l’imitazione di Piena Orchestra”. Nel trittico spicca la superba Seconda sonata, una delle pagine più belle dell'intero repertorio organistico italiano, la cui tristezza richiama l'Adagio di Remo Giazotto (ché di Albinoni non fu mai).
Completano il programma del CD, che si caratterizza per una presa del suono vivissima, la splendida “Pastorale coll’imitazione del suono de’ Zampognari (1822)”, brano melodico caratteristico, nello stile delle pastorali come solo in questo periodo le si sapeva concepire, in forma libera ed in più tempi, e la “Sinfonia per organo in D Minor (1805)”.
La scelta degli strumenti fatta da Sartore è calata sull’esperienza personale dell’autore e sulla sua attività a Senigallia. Lo strumento richiesto da Morandi ha una estensione della tastiera (da fa1 a do5) ed i registri spezzati; l’utilizzo limitato del pedale rimanda alla tipologia dell’organo callidiano, che fa da vero e proprio ideale sonoro dell’autore. Le registrazioni prescritte nelle raccolte a stampa corrispondono infatti sempre a registri disponibili negli organi Callido. A Senigallia erano allora presenti addirittura cinque strumenti costruiti da Gaetano Callido, ed una grande quantità (si parla di circa un centinaio) di esemplari costruiti dall’organaro veneto si trovavano nelle Marche, regione nella quale si esplicava principalmente l’attività di compositore del Morandi. Nei Monasteri di S. Cristina e S. Carlo (per cui furono composte le partiture rimaste manoscritte) esistevano inoltre due organi Callido. Nondimeno, dal 1804, Morandi era continuamente in viaggio accanto alla moglie, ed in contatto quindi con le più diverse realtà ed influenze musicali, e non va dimenticato che, in quanto data alle stampe, la prima raccolta era di necessità destinata ad un mercato eterogeneo e non poteva quindi fare riferimento esclusivo ad una determinata casa organaria. Le prime due raccolte di Sonate sono eseguite da Sartore sull’organo "E. Dacci" (1784), Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria, Santa Maria in Punta, mentre gli ultimi due brani sul "G.A. Pescetti" (1732-33), Chiesa di S. Giacomo, Polcenigo.
Due parole sull’interprete. Ci si aspetterebbe infatti che questo repertorio, da sempre considerato di nicchia, se non guardato in modo superficiale e supponente, fosse relegato a quelli che, in passato ed anche nel panorama organistico italiano odierno sono dei veri e propri specialisti del settore. Anche perché, ammettiamolo, suonare queste partiture in modo superficiale porta ad esecuzioni che sanno essere quasi fastidiose per l’appassionato. Per questo motivo sono rimasto affascinato dalla biografia dell’esecutore.
Il venticinquenne originario di Cittadella (Padova) è un organista e clavicembalista che spazia dalla musica liturgica a quella elettronica (sintetizzatori e arpa laser), nonché appassionato di regia. “Cercatore di Verità” (come gli piace definirsi) sin dalla giovinezza, ha consacrato la sua vita alla “Saggezza” giunta dalle epoche più remote. Autore e alchimista, è il rappresentante italiano della “Rosa+Croce Cattolica”. Collabora con “Psiche2” e sta portando alla luce opere collegate alla mistica e all’esoterismo cristiano. È stato in Siberia, nei monasteri, per conoscere i segreti della liturgia ortodossa ed imparare la lingua slavonica; poi Parigi e Versailles, passando per la Costa Azzurra, approdando in Sudamerica e in Oriente. Ha lavorato e studiato, seguendo la passione per la musica ed un bisogno profondo di spiritualità. Tornato in Alto Adige, si è fermato ad Auna di Sotto. Si è presentato al parroco don Theobald Obkircher edha fatto un provino. Suona attualmente l'organo nella Parrocchiale Santa Lucia, la chiesa più antica del comune di Renon: un mix di barocco e neoromanico. Il paesino - 270 anime - si è subito affezionato al giovane che vive in canonica, nell'appartamento preso in affitto dal parroco, mangia al ristorante “Wunder”, a due passi dalla chiesa, e quando suona l'organo incanta anche quelli che di musica non capiscono nulla ma, come lui quando era ancora un bambino, rimangono affascinati dal suono potente dell’organo.
Ecco, questo curriculum, dove non viene celebrata la carriera studentesca, i master conseguiti con i soliti nomi triti e ritriti, i concerti in località sperdute ed insignificanti, ma suscita curiosità nell’ascoltatore, è una delle parti più interessanti della registrazione. Perché la musica è fondamentalmente ciò che sì è in grado di trasmettere all’uditore, e questo CD è particolarmente gustoso e stuzzicante, fatto per essere ascoltato e riascoltato.
Rimaniamo dunque in attesa impaziente dei prossimi volumi.
__________
Note:
1 – L’editore Giovanni Ricordi, nel 1835, scriveva a Giovanni Morandi a proposito delle sue raccolte di sonate: “abbenché l’organo in questo genere non abbia progredito pure le pubblicherò giacché il nome vostro fa onore al mio stabilimento ed al mio catalogo. Come volete che scrivano altri per organo se codesti cani d’organisti suonano magari un Valzer di Strauss od un ballabile nel tempo dell’Elevazione?...”
2 – “Le ultime raccolte sembrano in vero un poco aride, ma le altre, in ispecie quelle composte nella gioventù, abbondano di simpatici ed originali pensieri, svolti con grande spontaneità e maestria.” (Giuseppe Radiciotti)
Si ringraziano:
- Giovanni Morandi: Sonate per organo, Prima raccolta (1808), edizione critica a cura di Gabriele Moroni, seconda edizione riveduta;
- Giuseppe Radole: Letteratura Organistica dal Tre- al Novecento, Edizioni Carrara;
- Gabriele Moroni: Giovanni Morandi – La vita e le opere