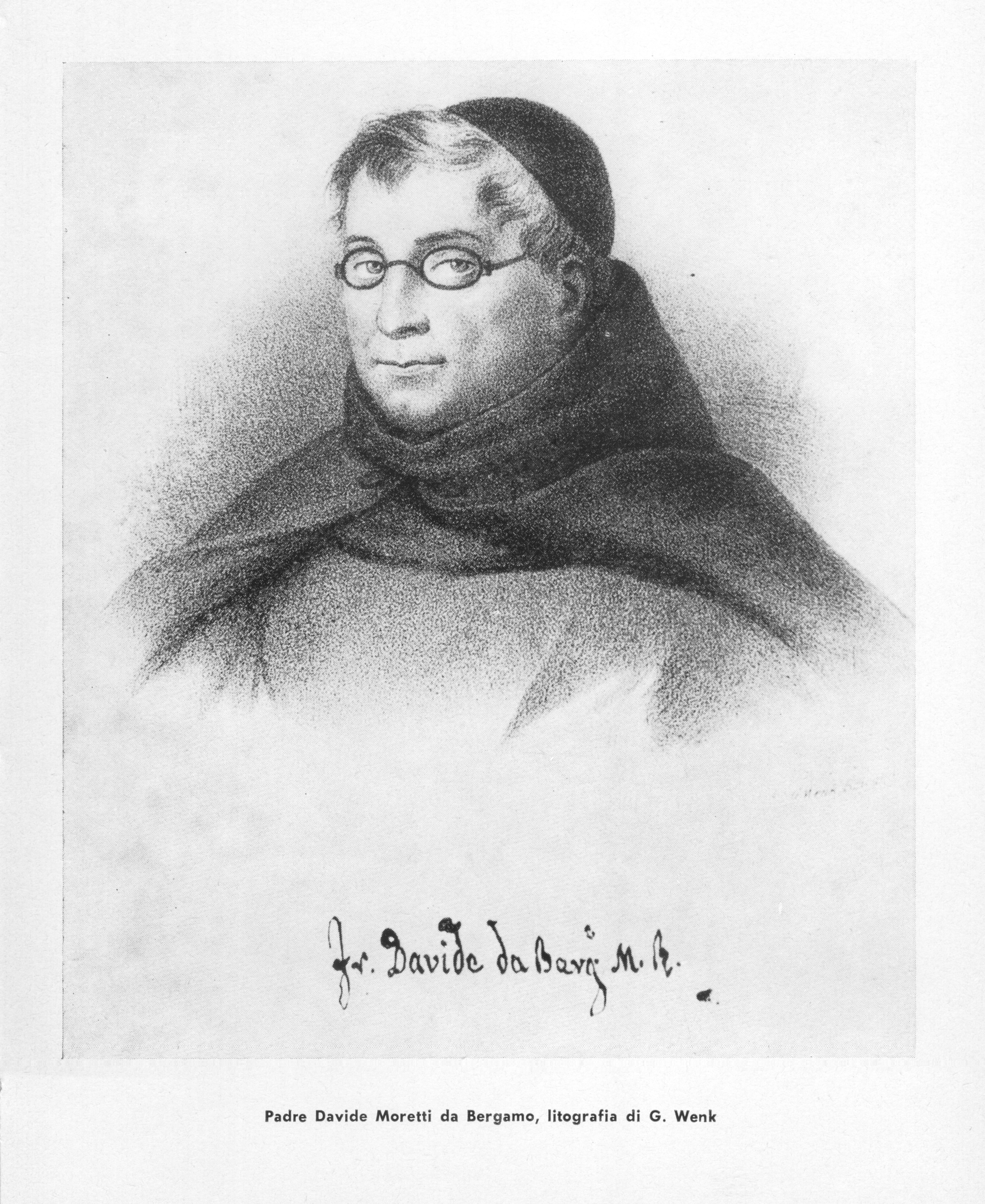Convegno su
Vincenzo Antonio PETRALI
31 Maggio 2013
Centro Comunale di Cultura di Valenza Po (AL)
Prof. Michele Bosio
Per un ritratto bio-bibliografico di Vincenzo Antonio Petrali
M° Arturo Sacchetti
Vincenzo Antonio Petrali: l'uomo, il compositore, l'interprete ed il didatta
M° Andrea Macinanti
Da Petrali a Bossi: il passaggio del testimone
Ing. Giuseppe Monari
La riscoperta discografica di Tactus del patrimonio organistico e organario italiano
M° Giulio Piovani
La “riesumazione” di Petrali: evoluzione di un progetto ardito e necessario
ESTRATTO DELL'INTERVENTO DI MICHELE BOSIO Per un ritratto bio-bibliografico di Vincenzo Antonio Petrali:
1. Premessa
Cercare di condensare in poco spazio una vita straordinaria come quella di Vincenzo Antonio Petrali è compito assai arduo, ma ci proveremo lo stesso; partendo non dall’inizio, bensì dalla fine.
2. Gli estremi si toccano
Il 24 novembre 1889 – dopo breve malattia di natura epatica – il Nostro si spense all’età di 57 anni a Bergamo. La Chiesa che egli aveva sempre servito – arricchendo con grande musica la celebrazione dei sacri riti – purtroppo non gli rese i doverosi onori funebri, macchiandosi così di un gravissimo torto.
Nel 1883 il Petrali – rimasto vedovo di Maria Ottolini di Crema – sposò in seconde nozze Carolina Cicognara di Bergamo con rito civile, poiché di religione protestante. Cosicché, alla sua morte, i ministri del culto vietarono il funerale religioso e impedirono la sua tumulazione, accanto alle salme cristiane, nel cimitero di Bergamo.
Leggiamo, infatti, ne «La Provincia», XI, n. 142 (27 novembre 1889) il seguente inciso, tratto a sua volta da «La Gazzetta di Bergamo»:
«[...] Noi sappiamo – scrive la Gazzetta di Bergamo – che il direttore del nostro Conservatorio, il comm. Cagnoni [Antonio], i professori e gli artisti della città nostra volevano rendere al caro estinto un tributo d’affetto e di onore coll’esecuzione d’una messa funebre dello stesso comm. Cagnoni. Ma qui viene il brutto: il Petrali era ammogliato civilmente con una protestante, e perciò dai ministri del Dio della misericordia e del perdono si nega una prece e l’ingresso della sua salma nel sacro tempio. Non basta. Quegli artisti che osassero cantare sul feretro, non saranno chiamati in avvenire a prendere parte alle sacre funzioni. Né basta ancora. La salma non può essere tumulata entro i recinti della sacra dimora dei defunti, e tutto questo per colui che tanto e più d’ogni altro aveva contribuito a rendere più solenni le sacre funzioni e ad elevare al cielo nel tempio del Signore.»
Le notizie biografiche sul Petrali sono piuttosto esigue e quasi tutte sparpagliate, il piccolo (8 pagine), ma prezioso volume di Aristide Dragoni – Vincenzo Petrali, Bergamo, Istituto di Arti Grafiche, 1899 – è probabilmente l’opera su cui si sono basate tutte le successive biografie.
Riportiamo di seguito una selezione della bibliografia storica su Petrali dal 1889 sino al 1952, anno in cui il musicologo Federico Mompellio dedicò a Petrali il primo attendibile ed esauriente profilo biografico all’interno dell’imprescindibile monografia su M. Enrico Bossi [Marco Enrico Bossi, Milano, Hoepli, 1952].
- Necrologio in «Atti dell’Accademia dell’Istituto Musicale di Firenze», XXVIII (1890), p. 22.
- Necrologio in «Musica Sacra» XIV (1890), p. 25.
- Aristide Dragoni, Vincenzo Petrali, Bergamo, Istituto di Arti Grafiche, 1899.
- Vittorio Scotti, Vincenzo Petrali in «Cremona», II (1930), n. 6, pp. 351-354.
- Giulio Cesare Paribeni, Luigi Orsini, Ettore Bontempelli, M. E. Bossi il compositore-l’organista-l’uomo-l’organo in Italia, Milano, Erta,1934.
- Azio Samarani, Commemorazione di Vincenzo Petrali nel cinquantenario della morte, Crema, Tipografia La Moderna, 1940.
- Federico Mompellio, Marco Enrico Bossi, Milano, Hoepli,1952.
Mompellio è anche il primo studioso a chiarire l’esatto anno di nascita di Petrali, non il 22 gennaio del 1832, bensì del 1830: «L’anno 1832, dato dai dizionari musicali – scrive il Mompellio – è errato; è invece esatto il 1830, secondo il certificato di nascita».
Il musicologo genovese attinse dalla stampa coeva all’attività di Petrali – soprattutto dalle recensioni del famoso critico Filippo Filippi – ed ebbe anche la possibilità di consultare direttamente Ettore Petrali Cicognara, generale dell’esercito italiano (con predilezione per la composizione, si vedano i diversi brani pubblicati nelle annate de «L’Organista Liturgico», Bergamo, Carrara), nato dal primo matrimonio di Vincenzo con Maria Ottolini di Crema e adottato in seguito da Carolina Cicognara. In possesso dei documenti paterni, con tutta probabilità, Ettore poté sottoporre al Mompellio diverse fonti. Vale la pena ricordare che – negli anni 1936, 1940 e 1961 – il Petrali-Cicognara donò alla Civica Biblioteca “Angelo Mai” di Bergamo un fondo musicale – che ha preso poi il suo nome – consistente in 61 pezzi tra autografi, copie manoscritte e pubblicazioni musicali del padre.
Nonostante Mompellio avesse già chiarito nel 1952 la svista sul vero anno di nascita del Petrali, l’errore ha continuato a perpetuarsi negli anni a venire sino ai giorni nostri.
Nell’autunno del 1909 a Crema si formò un Comitato Esecutivo a favore del ricordo marmoreo a Vincenzo Petrali, e venne promossa una serie di concerti presso il Teatro “Sociale”. Il ricavato sarebbe servito, appunto, per l’erezione di un busto commemorativo.
Il 6 luglio del 1913, venne inaugurato a Crema il tanto desiderato busto in memoria di Petrali. All’epoca si trovava – accanto al busto del cugino Giovanni Bottesini – sopra uno dei due pilastri dell’andito che conduce agli uffici del Municipio; e oggi giace quasi dimenticato – di nuovo accanto a quello del cugino – nel chiostro del Museo Civico di Crema (ex-Convento Sant’Agostino). Sta scritto nella lapide al di sotto di esso:
A
VINCENZO PETRALI
MUSICISTA
CHE PER FERVIDA FANTASIA
ACCOPPIATA AD ALTO MAGISTERO D’ARTE
ACQUISTÒ FAMA DURATURA
DI PRINCIPE DEGLI ORGANISTI
LA SUA CITTÀ NATALE
ORGOGLIOSA E MEMORE
NACQUE NEL 1832 – MORÌ NEL 1889
INAUGURATO 6-7-1913
Anche qui l’anno – inciso nell’immortale marmo – vivifica, attraverso gli occhi del lettore, un palese errore duro a morire. [...]
*** per leggere l'articolo completo, cliccare il collegamento qui sotto riportato ***